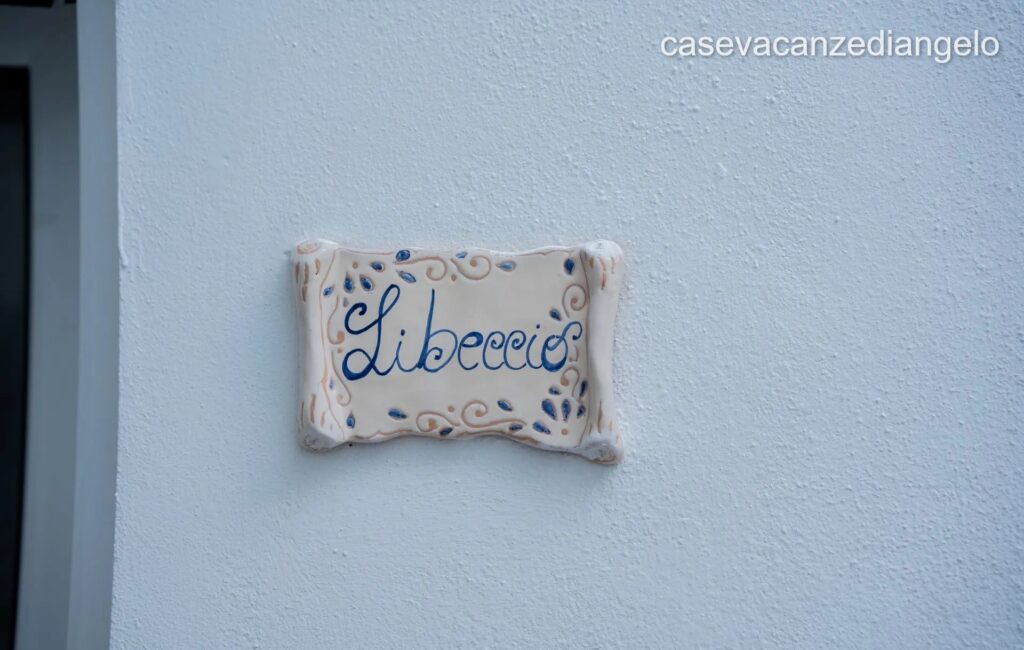Il Salento
Regione storica, geografica e culturale dell'Italia sud-orientale
Il Salento (Salentu e Salientu in romanzo salentino, Σαλέντο in greco salentino e Salènde in tarantino) noto anche come penisola salentina, è una regione storica, geografica e culturale della Puglia. Figurativamente costituisce il tacco dello stivale italiano ed è la zona più orientale d’Italia.
Gli abitanti dell’area, che comprende l’intera provincia di Lecce, gran parte di quella di Brindisi e la parte orientale di quella di Taranto, si distinguono per caratteristiche storiche, glottologiche e culturali diverse rispetto al resto della Puglia. Tali differenze culturali trovano origine nel sostrato greco che prevalse in alternativa di quello osco. Al sostrato greco antico si aggiungerà poi quello bizantino in epoca medievale, accentuando così la differenza con il resto della Puglia.
Sotto il profilo giuridico, il Salento fin dal tempo del Regno di Napoli (poi Regno delle due Sicilie) è quasi perfettamente coinciso con la circoscrizione territoriale denominata Terra d’Otranto, esistita fino all’unità d’Italia e successivamente ridenominata provincia di Lecce fino allo smembramento avvenuto nel 1923 e nel 1927 con la costituzione delle province di Taranto e Brindisi.
Toponimo
Il toponimo Salento ha origini incerte; è ignoto agli antichi, i quali usano soltanto l’etnico Sallentini o Salentinoi per indicare una parte degli abitanti della regione (l’altra parte era costituita dai Calabri). Il loro territorio coincide con la penisola salentina, abitata in origine dagli Iapigi che i Greci chiamavano Messapi.
Uno studio di Mario Cusmai lo farebbe derivare da “salum”, inteso come “terra circondata dal mare”.
«Salento in messapico significherebbe “mare”: ce lo confermerebbe Verrio Flacco che dice “Salentinos a salo dictos” (cfr. il greco hals, halòs e il latino salum, mare)»
(Verrio Flacco, Sul significato delle parole, fr. apud Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.))
L’ipotesi di Marco Terenzio Varrone, invece, è quella di un’alleanza stipulata “in salo”, ovvero in mare, fra i tre gruppi etnici che popolarono il territorio: Cretesi, Illiri e Locresi. Strabone, nella sua opera Geografia cita i Salentini in quanto coloni dei cretesi:
(GRC)
«Τοὺς δὲ Σαλεντίνους Κρητῶν ἀποίκους φασίν»
(IT)
«Dicono che i Salentini siano coloni dei Cretesi.»
(Strabone, Geografia. L’Italia, libri V e VI.)
Inoltre, al principio dell’epoca imperiale (verso la fine del I sec. a.C.), lo stesso Strabone affermava che al suo tempo la maggior parte dei geografi e degli scrittori per indicare il Salento utilizzava intercambiabilmente i nomi di Messapia (dal nome dell’antica tribù dei Messapi, stanziata tutt’attorno al golfo di Taranto fin dall’epoca della Magna Grecia), Iapygia (dal nome del popolo degli Japigi, comprendente tre tribù fra cui quella dei Messapi), Salentina (dal popolo dei Sallentini, stanziati in epoca romana sul versante ionico del Salento) e Calabria (dal popolo dei Calabri, pure stanziati in epoca romana lungo il versante adriatico del Salento).
Con l’istituzione delle regioni augustee, intorno al 7 d.C., fu però prescelto il nome Calabria: nacque così la regio II Apulia et Calabria che comprendeva, oltre all’Apulia e alla già citata Calabria, anche i territori dei Sallentini e degli Hirpini. Nel IV secolo in luogo della Regio II fu istituita la provincia di Apulia et Calabria. Intorno al VII secolo fu eretto il ducato di Calabria che si estese anche al Bruzio (l’attuale Calabria), finché nel secolo successivo i Longobardi riuscirono a conquistare quasi tutto il Salento. Da allora in poi il toponimo Calabria trasmigrò alla terra che attualmente ne porta il nome, mentre il Salento fu considerato parte integrante della Puglia. Successivamente dall’antico toponimo “Salentina” è stato tratto l’attuale nome della penisola.
Geografia
«Terra tra i due mari Adriatico e Ionio partendo da una linea condotta dal punto più interno del golfo di Taranto fino alla contrada del Pilone a nord di Ostuni. L’asse longitudinale di questa penisola è da prima diretto da WNW ad ESE dai colli di Martina Franca fino all’istmo salentino, dove è una strozzatura nel continente larga 36 chilometri, compresa tra la Torre Rinalda sull’Adriatico e quella di Porto Cesareo sullo Jonio. Di qui si ripiega bruscamente nella direzione NNW a SSE e va a terminare quasi in punta al Promontorio japigio o Capo di Santa Maria di Leuca.»
(Cosimo De Giorgi, Cenni di geografia fisica della provincia di Lecce, Lecce, 1889)
La penisola salentina, da un punto di vista meramente geografico, è separata dal resto della Puglia da una linea ideale che dal punto più interno del Golfo di Taranto (nel territorio di Massafra) arriva fino all’Adriatico, in corrispondenza dei resti della città messapica di Egnazia (nel territorio di Fasano), ai confini con l’antica Peucezia e dai colli di Martina Franca si protende nel Mediterraneo verso la Grecia e l’Albania
Tuttavia, intendendo il Salento come un’entità culturale, più che geografica, si è soliti spostare i confini leggermente più a sud, lungo la linea che da Taranto, attraverso Grottaglie e Ceglie Messapica, giunge fino a Ostuni, la cosiddetta Soglia messapica.
Così definito, il Salento ha quali suoi vertici ideali:
Taranto, nell’omonima provincia;
Pilone, nel territorio di Ostuni in provincia di Brindisi,
Santa Maria di Leuca, nel territorio di Castrignano del Capo in provincia di Lecce, che rappresenta il centro abitato più meridionale della Puglia.
La penisola salentina è il territorio più a Est d’Italia e Punta Palascìa o Capo d’Otranto ne costituisce l’estremità orientale, distante dall’Albania 72 km attraverso il Canale d’Otranto.
Ambiente
Il paesaggio presenta molti elementi caratteristici. L’agro salentino è quasi ovunque coltivato e la vegetazione arborea è per lo più costituita da distese di ulivi secolari, dai tronchi contorti e di grandi dimensioni. La proprietà terriera è generalmente suddivisa in piccoli appezzamenti, separati dai tipici muretti a secco. La pietra è da sempre usata anche per realizzare diverse costruzioni a secco, impiegate dai contadini per riposare o per riporvi gli attrezzi da lavoro. Tali costruzioni (definite a seconda delle zone furnieddhi, pajare, ecc.) sono più simili ai nuraghi sardi che ai trulli pugliesi. Numerose sono le masserie fortificate e non, risalenti per lo più al XVI, XVII e XVIII secolo; altra peculiarità del territorio sono le cosiddette cuneddhre, edicole votive situate anche nelle campagne con l’immagine del santo all’interno, e le chiesette rurali.
I paesi, in genere poco popolosi, hanno un aspetto tipicamente mediterraneo e sono caratterizzati dal bianco intenso delle costruzioni che li rende abbacinanti nelle giornate di sole. In un paesaggio orograficamente poco caratterizzato, essi spiccano quindi rispetto alla campagna, dominata dal colore rossiccio di un terreno dove è alta la presenza di ferro, a differenza della Puglia centro-settentrionale, dove invece questa colorazione sanguigna è molto più rara. Da un punto di vista cromatico il mare assume una colorazione blu scuro se osservato dalle alte scogliere a strapiombo sul mar Adriatico, e più tenue ma vario nelle sue sfumature (verde smeraldo, verdino, celeste, ecc.) se osservato dalle spiagge sabbiose o dalle basse scogliere del mar Ionio. Lungo le coste di entrambi i mari, i centri abitati non sono numerosi; è però possibile ammirare le numerose e antiche torri costiere di avvistamento, di forma quadrangolare o circolare, costruite nel corso dei secoli per difendersi dall’arrivo delle orde piratesche.
Flora
Si stima che la flora nel Salento annoveri circa 1.500 specie. Una delle peculiarità della flora salentina è quella di comprendere numerose specie con areale mediterraneo-orientale, assenti nel resto della penisola, e diffuse invece nella penisola Balcanica, condizione questa favorita dalla vicinanza delle opposte sponde adriatiche (tra Capo d’Otranto e le coste albanesi ci sono solo 70 km) e dalla presenza di condizioni ambientali analoghe. Sono presenti comunque anche numerose specie ad areale mediterraneo-occidentale, condivise con il resto della penisola.
Oltre che dai già citati oliveti secolari e vigneti che caratterizzano il territorio, la vegetazione è anche costituita soprattutto dal fico d’India, che cresce spontaneamente sia all’interno sia lungo la costa, dal fico, che regala i suoi dolci frutti sul finire dell’estate e dal mandorlo, che inizia a fiorire solitamente a febbraio. In primavera, la terra sotto gli ulivi, il ciglio dei sentieri e delle strade, nonché gli interstizi dei muretti a secco, si ricoprono di fiori in un’esplosione cromatica che va dal rosso dei papaveri al giallo e al bianco delle margherite. Durante l’estate, il colore sanguigno della terra diventa protagonista con il verde della macchia mediterranea. Le bacche policrome annunciano poi l’autunno e il successivo mite inverno.
Tra le specie condivise con i paesi balcanici, la più maestosa è senz’altro la quercia vallonea (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis), presente in Italia solo nel Salento meridionale, nei dintorni di Tricase. Altra specie di quercia ad areale mediterraneo tipica del Salento è la quercia spinosa (Quercus coccifera) che qui forma boschi puri o misti con il leccio. Altre specie a diffusione balcanica sono il kummel di Grecia (Carum multiflorum), la poco diffusa erica pugliese (Erica manipuliflora) e altre specie che popolano le garighe salentine quali lo spinaporci (Sarcopoterium spinosum) e lo spinapollici (Anthyllis hermanniae).
Sulla costa rocciosa tra Otranto e Leuca si possono trovare specie endemiche della flora rupestre come il fiordaliso del Capo di Leuca (Centaurea leucadea), l’alisso di Leuca (Aurina leucadea), il garofano salentino (Dianthus japigycus), la campanula pugliese (Campanula versicolor), il cardo-pallottola spinoso (Echinops spinosissimus) e il limonio salentino (Limonium japigycum), mentre sulle dune crescono macchie di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus).
Notevole è anche la presenza di molte specie di orchidee spontanee, quali l’Anacamptis laxiflora, l’Anacamptis palustris l’Ophrys apifera, l’Ophrys candica e la Serapias politisii che crescono nelle aree paludose, nei pascoli o tra la macchia mediterranea.
Fauna
Per quanto concerne la fauna del Salento, vi si possono annoverare numerose specie di uccelli quali la gru, l’airone grigio (Ardea cinerea), il germano reale (Anas platyrhynchos), il tarabuso (Botaurus stellaris), la ghiandaia marina (Coracias garrulus), il fistione turco (Netta rufina), il gheppio (Falco tinnunculus), nonché numerose specie di rettili, come lucertole e gechi, di mammiferi, quali ricci, volpi e faine, e di artropodi, quali scorpioni, tarante e lepidotteri come per esempio Amata phegea. Da segnalare inoltre la presenza di mammiferi quali il tasso, il cinghiale, e più recentemente il ritorno del lupo appenninico.